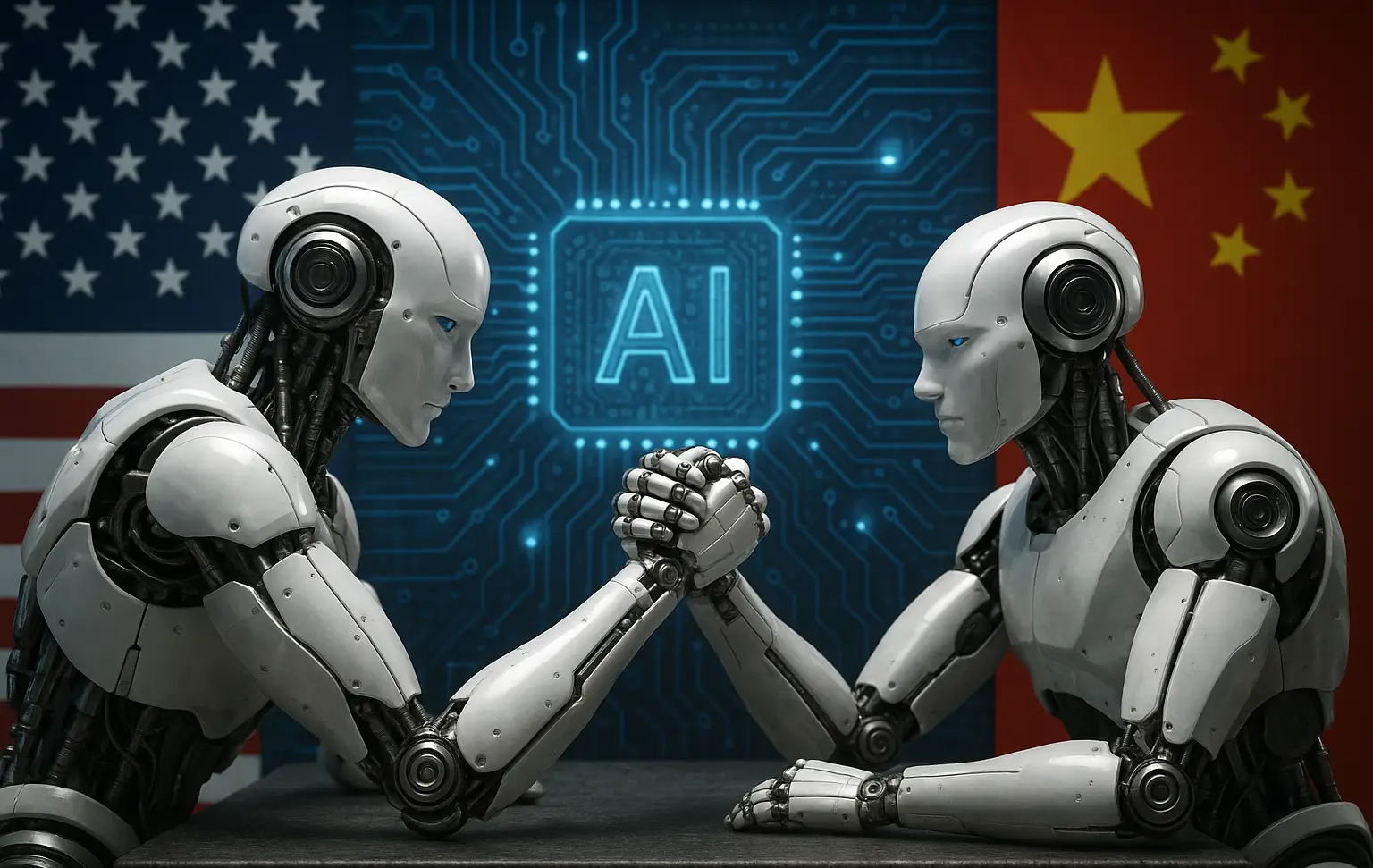Le dichiarazioni di Sam Altman, CEO di OpenAI che ha parlato per la prima volta senza remore della bolla speculativa che incombe sull’intelligenza artificiale, non sono nulla di sorprendente. Non per chi, se non altro, ha sempre espresso crescenti preoccupazioni di fronte a quotazioni di mercato che impennavano in maniera folle in assenza di ritorni sugli investimenti, dividendi, valutazioni sullo stato del debito delle compagnie di settore. Di fatto, Altman ha sfondato una porta aperta. Ma come e perché quella che è stata unanimemente considerata (in maniera fallace e superficiale) la più grande rivoluzione tecnologica umana sta rischiando di generare un cataclisma generale?
All’inizio degli anni ’90, il mondo occidentale viveva una fase di entusiasmo piuttosto inedita. Il crollo dell’Unione Sovietica, il fallimento del blocco comunista e la diffusione del capitalismo consumistico avevano posto le condizioni per un ottimismo generale, seppur con un’economia americana in recessione a causa degli alti tassi d’interesse (fino al 10%) (1), della crisi nera delle savings & loan associations e dei prezzi esorbitanti del petrolio post-guerra del Golfo. Ma l’euforia non segue schemi razionali, e la serie di pesanti tagli ai tassi della Fed (oltre 7 punti percentuale in 5 anni) causerà una pesante fase di espansione economica che, insieme all’allegra intraprendenza di microimprenditori informatici americani, porterà ad uno stravolgimento totale delle regole dei mercati finanziari. Dopo il lancio pubblico del World Wide Web nel 1991, l’euforia montante si apprestava a diventare ossessione: nessuno, e dico nessuno, aveva intenzione di perdere il treno del “web”. E così, ogni società “.com” divenne qualcosa su cui puntare a prescindere, bypassando ogni valutazione di rischio, tralasciando ogni tipo di controllo, analisi sui dividendi, aspettative di ritorno sugli investimenti. La parola d’ordine era una sola: comprare. Il mercato avrebbe fatto il resto. E così, ogni singola startup che avesse alla propria base una matrice informatica venne sommersa di investimenti, triplicando il prezzo ad azione in una singola seduta di mercato. Tanto i traders quanto i value-investors erano felici e contenti, così come gli istituti bancari, i governi che si avvalevano dei servizi delle nascenti startup tech. All’inizio degli anni duemila, la tecnologia aveva completamente monopolizzato i mercati azionari.
Dal 1998 al 2000, la bolla ha raggiunto il suo apice speculativo. Il Nasdaq era aumentato di cinque volte, passando da meno di 1.000 punti nel 1995 a oltre 5.000 nel 2000, con un incremento del 400% tra il 1995 e il picco di marzo 2000 (2). Il settore tecnologico rappresentava più del 34% di tutto l’S&P 500: ogni cosa era in internet, e internet era in ogni cosa.
Ma quando i soldi iniziano a girare e la domanda aumenta sempre più, ecco che i tassi al 2% iniziano a non essere più sostenibili. Stava arrivando l’inflazione, apparentemente nulla di troppo straordinario dopo un boom di mercato. Ma l’aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve, sebbene modesto, ha reso i prestiti più costosi e ha prosciugato i capitali di investimento. Il Nasdaq è crollato dagli oltre 5.000 punti del marzo 2000 a poco più di 1.000 il 4 ottobre 2002, con una perdita del 78% (3). Il panico è stato amplificato da grandi ordini di vendita da parte di aziende leader come Dell e Cisco, causando una perdita del 10% del valore di mercato in poche settimane. Entro la fine del 2001, la maggioranza delle società dot-com quotate in borsa era fallita, con trilioni di dollari di capitale di investimento evaporati. Il crollo ha contribuito a una recessione lieve nel 2001, durata otto mesi, con l’S&P 500 che ha perso il 49% del valore tra il 2000 e il 2002.
Ma come è stato possibile, tutto questo? Un intero settore può implodere su sé stesso per una semplice manovra correttiva delle banche centrali? Può, se costituito per la stragrande maggior parte da società con modelli di business inefficaci o inesistenti, che si tenevano in piedi soltanto grazie ai continui investimenti e alla speculazione dei traders e dei growth-investors. La maggior parte delle tech companies, di fatto, offriva dividendi nulli o irrisori, investiva il 90% (5) dei propri guadagni in marketing e promozione di massa, tempestava ogni spazio pubblicitario esistente con la propria presenza, e questo ha portato ad una vera e propria ossessione per ogni cosa che avesse un software al proprio interno. Gli investitori avevano abbandonato ogni tipo di prudenza per paura di perdere opportunità, portando a valutazioni gonfiate: azioni di società senza ricavi o prodotti finiti triplicavano o quadruplicavano nel giorno dell’IPO. Nel primo trimestre del 2000, ci sono state 91 IPO legate a Internet. Un evento emblematico è stata la fusione tra AOL e Time Warner nel gennaio
2000, valutata 183 miliardi di dollari, che è diventata il più grande fallimento di merger nella storia (5). Il traino principale per ogni società dot-com era l’accesso al credito per gli investitori, facilitato dai bassissimi tassi d’interesse. E così il sogno è diventato un incubo alla stessa velocità.
Le analogie e le differenze tra il contesto storico attuale e quello delle dot-com sono molte, ma per avere un quadro dettagliato della situazione è necessario analizzare nel dettaglio il settore per capire la situazione reale, senza cadere in facili allarmismi o adagiarsi sugli allori.
La prima cosa che salta all’occhio è un’analoga situazione di dominio finanziario delle tech companies nel panorama mondiale. Ad oggi, il settore tecnologico rappresenta il 32% del peso dell’S&P 500 (1), e il dato preoccupante è che oltre un terzo della capitalizzazione dell’intero indice sia racchiusa delle “magnifiche sette”: Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Nvidia, Meta Platforms e Tesla (3). Il mercato, di fatto, dipende come all’epoca da pochi colossi tecnologici. (1)
Le big tech, di fatto, dipendono strutturalmente dall’implementazione di intelligenza artificiale nei propri processi produttivi e di governance, oltre che nei servizi venduti agli utenti. Questo è uno dei primi, grandi grattacapi: la crescita esponenziale deve affiancarsi a livelli di perfezionismo ugualmente esponenziali. La sola Nvidia negli ultimi dieci anni ha visto il valore delle proprie azioni crescere del 26.000%, la propria capitalizzazione del 42.400% (4) (parliamo di oltre 4 trilioni di dollari), con i primi segni di cedimento ravvisati nei rapporti sugli utili di qualche settimana fa: disattesi.
Ad ogni modo, gli analisti non sembrano eccessivamente preoccupati. Lo storico dei titoli delle big tech in ascesa è troppo fiammeggiante per pensare di scendere ora dal carro vincente. E soprattutto, a differenza delle dot-com, le big tech odierne sembrano aver trovato il modo di procrastinare la resa dei conti in maniera più furba con il sistema del buyback, ovvero utilizzare la recompra delle azioni sul mercato per aumentarne artificialmente il prezzo attraverso la riduzione dell’offerta e garantendo agli azionisti un rialzo dei propri asset al posto del dividendo tradizionale. Furbi. Eppure, sempre più voci fuori dal coro stanno iniziando a smobilitare i propri investimenti nell’azionario per fare il pieno di treasury, bond, materie prime. Perché?
Perché, a differenza degli anni ’90 e 2000, c’è un fattore fondamentale che sta riscrivendo le regole del gioco e a cui nessuno sembrava pensare: la competizione geopolitica. Nello specifico: la Cina. Con il lancio di DeepSeek, i cinesi non hanno dimostrato supremazia tecnica nell’AI né nello sviluppo digitale. Hanno fatto di meglio (o peggio, a seconda di come la si voglia vedere): hanno abbattuto il dilemma dei costi. Il dramma delle big tech presenti e passate è analogo in un punto fondamentale: i costi enormi riducono sensibilmente il ritorno sugli investimenti. Un rapporto del Massachusetts Institute of Technology mette in luce il fatto che il 95% dei piloti AI aziendali fallisce nel generare profitti misurabili o accelerazione di revenue, nonostante miliardi investiti (6).
C’è un sostanziale elefante nella stanza, ignorato pressoché sempre in ogni tipo di discorso sul tema: la supply chain.
Ogni genere di componente elettronico, microchip o semiconduttore è prodotto con materiali critici che prendono il nome di “terre rare”. Tre dati: il 30-37% delle riserve mondiali di questi preziosi materiali è sotto diretto controllo cinese; la Cina ha una quota del 70% della produzione globale di terre rare estratte dai giacimenti; la Cina ha raggiunto una cifra vicina al 90% della capacità globale di raffinazione e separazione delle terre rare (7). Questo cosa significa, nel concreto?
Che l’intero settore tecnologico americano (e quindi globale) dipende interamente da catene di approvvigionamento che non solo si basano su un costoso import, ma che fanno capo al suo nemico strategico per eccellenza. Nemico strategico che, nell’attuale clima d’incertezza e competizione, sta utilizzando blocchi e restrizioni all’export di terre rare come leva geopolitica, compromettendo in maniera vitale l’intera spina dorsale delle big tech. E dunque, del mercato intero.
La Cina ha replicato il modello più in voga di OpenAI con costi infinitesimamente inferiori, mostrando tutte le fragilità di un’ondata di sviluppo tecnologico tremendamente simile a quella delle dot-com. Le tech & AI companies ora sono finanziariamente più solide, godono di più aiuti dai governi e soprattutto hanno trovato il modo di essere onnipresenti nella produzione di qualsiasi bene o servizio, ma sempre più analisti ravvisano rischi di governance, quarterly deludenti, calo dei margini. I costi di produzione e di gestione, allo stato attuale, non possono essere abbattuti.
Fino a che la Federal Reserve continuerà ad essere morbida sui tassi e il dollaro manterrà una relativa debolezza, l’accesso al credito sarà sufficientemente semplice da garantire rifinanziamenti, proroghe dei debiti, ricapitalizzazioni, split azionari e chi più ne ha più ne metta. Ma quando l’inflazione tornerà ad essere un problema e nella Cina prenderà forma il pensiero di stritolare la supply chain dei propri rivali, quale destino attenderà l’intera economia globale?
- Trading Economics: https://it.tradingeconomics.com/united-states/interbank-rate – https://tradingeconomics.com/united-states/stock-market
- Duignan, Brian. 2025. Dot-com bubble. Edinburgh. Britannica. Disponibile presso: https://www.britannica.com/money/dot-com-bubble
- Krauskopf, Lewis. 2024. Echoes of dotcom bubble haunt AI-driven US stock market. New York. Reuters. Disponibile presso: https://www.reuters.com/markets/echoes-dotcom-bubble-haunt-ai-driven-us-stock-market2024-07-02/
- Trading Economics: https://tradingeconomics.com/nvda:us
- Hayes, Adam; Rasure, Erika; Williams, Patrice: Understanding the Dotcom Bubble: Causes, Impact, and Lessons. 2025. Investopedia. Disponibile presso: https://www.investopedia.com/terms/d/dotcom-bubble.asp
- Challapally, Aditya; Pease, Chris; Raskar, Ramesh; Chari, Pradyumna: The GenAI Divide – State of AI in business 2025. 2025. Cambridge, Massachusetts. Massacusetts Institute of Technology. Disponibile presso: https://mlq.ai/media/quarterly_decks/v0.1_State_of_AI_in_Business_2025_Report.pdf
- Andrew-Speed, Philip; Hove, Anders: China’s rare earths dominance and policy responses. 2023. Oxford, United Kingdom. The Oxford Institute for Energy Studies. Disponibile presso: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2023/06/CE7-Chinas-rare-earths-dominance-andpolicy-responses.pdf